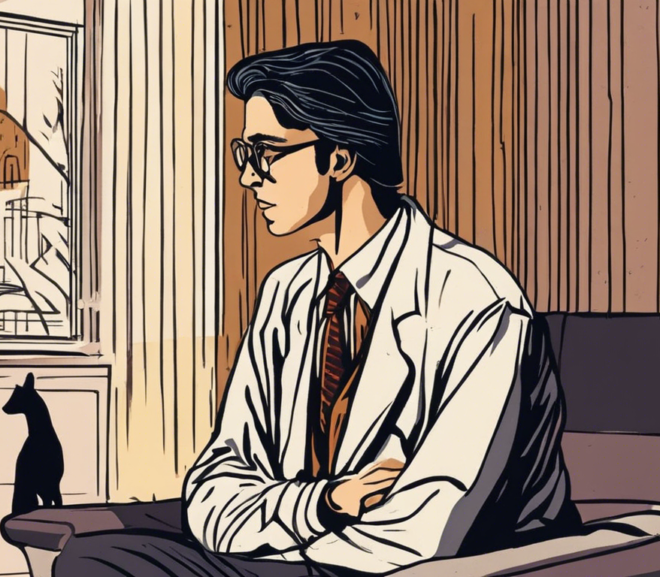La perdita dei capelli non è solo un fatto estetico: è spesso anche un’esperienza emotiva, sociale, e purtroppo, giudicata. Il bald shaming, conosciuto anche come…
Categoria: Corpi e binarismo
Il corpo e quanto viene influenzato dal binarismo di genere, da regole sociali obsolete e dal giudizio
I maschi hanno il ciclo? Sveliamo l’arcano Vi siete mai chiesti se anche gli uomini hanno il ciclo? Sì, proprio quel ciclo mensile che caratterizza…
Terapia sessuologica di coppia: alla ricerca del punto… di vista Premessa doverosa: questo articolo è stato scritto dal punto di vista di chi non ha…
Male gaze: che cos’è, e cosa comporta? Negli ultimi mesi, TikTok pullula di video sulle “pick me girls”, ovvero ragazze che, sulla base di stereotipi,…
Metrosexual: significato e stile di vita dei metrosessuali Il termine metrosexual è stato inventato nel 1994 dal giornalista inglese Mark Simpson per indicare una nuova…
Uomini in reggiseno: breve storia del reggiseno La storia di questo indumento, in realtà, è molto antica. Già nell’antico Egitto e in Grecia, le donne…
L’atteggiamento verso le donne calve è un aspetto critico della società che merita una seria considerazione. Spesso, quando si parla di calvizie, l’attenzione è concentrata…
Peli nella donna: depilazione nell’Antichità La donna, fin da tempi antichi, deve rispondere ad un certo ideale di bellezza. Tra questi canoni vi è anche…
Le parolacce fanno parte del nostro linguaggio. Questo vale sia per uomini e sia per donne. Dirle o meno è una nostra decisione. Spesso vengono…
L’articolo presenta in grandi linee il concetto Sex Working Da anni si parla di prostituzione però qui si punisce il cliente. Un tipo di attenzione…